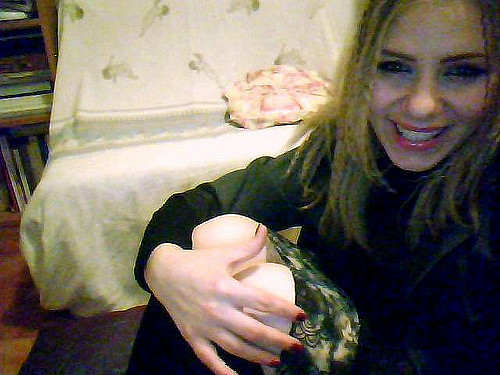3 piccoli consigli che vorrei aver dato a me stessa appena laureata
7 anni fa oggi sono finita contro, anzi, dentro una porta a vetri. Ne uscii miracolosamente intera: mentre la porta rovinava in un frastuono di schegge, io mi aggrappai all’impalcatura in acciaio, recuperai l’equilibrio e poi urlai a chi era fuori e aveva sentito solo il fracasso di una miriade di vetri in frantumi: «Sto bene! Sto bene!». Al solito, più che il mio stato fisico, fu il pensiero della paura e del conseguente cazziatone dei padroni di casa a tenermi lucida. Capitemi: erano i miei genitori; la porta una porta importante, quella del box doccia e la sottoscritta una giovane donna sotto pressione per la prova a cui stava per esser sottoposta, non solo la fine di un percorso di studi ma la sua convalida pubblica: la seduta di Laurea.
Poteva starci, insomma, che accadesse una cosa del genere, che io e i miei tremassimo alla sola idea di quello che poteva succedermi se e solo se, e anche che ce la prendessimo un po’, palleggiandoci accuse per tutta la giornata, passandoci l’ansia come una palla, allungandola ai parenti perché sapessero: la mia sbadataggine, l’inadeguatezza delle suppellettili domestiche, il concreto problema di non poter più farsi una doccia senza inondare l’intera stanza, il nome dell’anticalcare giusto da far schiumare negli ingranaggi scorrevoli che mi avevano tradita.
– Allora, Raffaella come sta, come si sente da Dottoressa?
– Lascia stare che è finita contro, anzi, dentro la porta a vetri della doccia!
– Oddio!
– Tutto apposto, ha avuto il massimo dei punti.
– I punti? Siete in ospedale? Non farmi preoccupare!
– Intendevo i punti in seduta di laurea.
– Ah.Bene, che bella cosa, lo sapevo!
– Sì. Mo però dobbiamo riparare la doccia.
Essere uscita pressoché intonsa se non si tiene conto di una storta presa mentre ero sotto l’acqua (era stata proprio quella a farmi perder l’equilibrio) parve a tutti o forse solo a me stessa una sorta di rivelazione, un indizio fornito dal presente sul mio futuro qualunque fosse stato, una tranquillità validata dall’accidente in cui ero caduta: uscire viva e senza un graffio da quell’incontro ravvicinato con i vetri faceva di me una specie di prescelta come nei film di M. Night Shyamalan: sarei stata bene sempre, dopo allora. Avrei avuto un brillante futuro, dopo allora. Ero destinata a sopravvivere. As usual, direi.
– Per fortuna stai bene, tieni sette vite tu, come i gatti.
– Solo il pensiero di come potevi farti male mi fa venire il sangue al cervello. Vedi di non cadere mai più!
– Mettici ‘a capa in quello che fai!
– A ora ‘e mo’ potevamo stare in ospedale. E invece siamo all’Università!
E così mi laureai: il 23 novembre 2009, giorno dell’anniversario del Terremoto in Irpinia, con una tesi sugli Anni Ottanta a Sud in Storia Contemporanea, cattedra di Pietro Cavallo. Dopo anni di studi in cui le mie letture precoci e i film che guardavo, le canzoni che ascoltavo, avevano provocato qualche problemino e ogni mio testo veniva esaminato dagli adulti con un misto di orgoglio e inquietudine, ora utilizzavo la commedia italiana come fonte di analisi per gli avvenimenti del decennio in cui ero nata e cresciuta. Avevo fatto interviste per un’estate intera a persone che reputavo (e in alcuni casi reputo ancora) importantissime, vere e proprie chiavi dell’acqua per la comprensione del passato. Per mesi mi ero autoreclusa nel palazzo delle Poste, precisamente al secondo piano, Emeroteca Tucci, a cercare su giornali vecchi e pieni di polvere una traccia di futuro. Avevo prodotto 150 pagine abbastanza appassionate su un solo tema e quando il professore le aveva viste mi aveva detto: «Devi fermarti! Va bene così, va benissimo!». La mia tesi, di base, si chiedeva se erano nati prima gli sterotipi su Napoli e sul Sud o la cronaca e poi volevo capire se Billy aveva ragione quando in Scream di Wes Craven diceva che “i film non fanno nascere nuovi pazzi, li fanno solo diventare più creativi”. Mentre la scrivevo, per non farmi mancare niente, avevo anche tentato l’ingresso a varie scuole di specializzazione: ero entrata ovunque avessi provato ad entrare.

Ma le cose andarono diversamente. Una settimana dopo la laurea, anzi 6 giorni dopo la laurea, prima ancora che avessi recuperato la pergamena o mi fossi accertata che la segreteria studenti avesse registrato la mia sfolgorante ascesa di cui restava solo prova fotografica, mentre avevo ancora nelle orecchie la voce del professore che mi chiama a conferire presentandomi come una promettente scrittrice davanti agli altri compagni di avventura e allo stuolo di parenti giunto non solo a festeggiare ma a verificare l’esistenza di una prole provvista di laurea nella famiglia Ferré, il primo esemplare (e Dio solo sa lo scuorno e la paura che il professore nominasse i titoli dei miei libri, non tanto per il primo, ma per il secondo, all’epoca appena uscito “La mia banda suona il porn”), feci un colloquio. Più un incontro propedeutico che un colloquio, okay, visto che si tenne in un bar del Centro Direzionale, il Fly Food, ma fu abbastanza perché mi trasferissi qui dove sono oggi, Napoli, e pensassi che avevo davanti solo un brillantissimo e promettente futuro. Perché avevo un nuovo lavoro (Dove? Ma in tv, ovvio). Perché ero finita contro, anzi, dentro una porta a vetri, e non mi ero fatta niente.
Mi piacerebbe tanto poter tornare indietro e dare alla ragazzina che ero qualche consiglio: nonostante mi sentissi già una giovane donna dalla camminata decisa e sicura – portavo scaldamuscoli sugli stivali, all’epoca, e mai le calze, gambe nude anche a gennaio – so che era quello di cui avevo più bisogno e che cercavo ovunque, nelle persone e nelle cose che mi succedevano come una che sfogli un vocabolario senza sapere di quale parola, esattamente, vuole conoscere il significato, perché magari servono tutte, non si può mai sapere.
E allora, dopo 7 anni, ho deciso stamattina di darmeli quei consigli: 3. Pochi perché non ho raggiunto nessuna consapevolezza zen; pochi perché sono quelli importanti e più di 3 cose alla volta – lo dico io ma anche il pragmatismo americano delle agende – non ci si può ricordare mai.
E dunque, cominciamo.
Per esigenze narrative, la Raffaella ventiseienne fa in queste righe la controparte della trentatrenne che sono oggi: siate buone con lei, è appena scampata ad una caduta nella porta a vetri.
1. LA VITA CHE HAI DAVANTI NON È L’UNICA POSSIBILE.
Lo so. Lo so. Sei fresca di laurea e di teoria, di pagine e pagine di libri, di fogli scritti che portano la tua firma, di abbracci genitoriali e soddisfazioni personali e chiedi al domani solo una cosa: la pratica. Non farlo. Non credere di aver imparato già tutto e di dover, ora, solo fare. Hai fame di sorrisi e braccia intorno a te, come canta Baglioni, bene, e anche di soldi perché mentre studiavi e lavoravi hai anche sognato: di non dover più contarti gli spiccioli per le fotocopie e le sigarette; di poter comprare i libri e smettere di prenderli in prestito da una biblioteca che leggere un libro preso in prestito è come stare con un uomo sposato: devi sempre sperare che non ti piaccia troppo. Anche se “fare” è quello di cui hai voglia più di ogni altra cosa, datti il tempo di aprire gli occhi, viaggiare con i piedi e la fantasia, vedere posti nuovi e lontani, abituarti alla luce di questa vita vera che tanto hai aspettato.
– Non fingere di non vederne i lati brutti perché sono quelli che sgrosseranno i tuoi desideri;
– Non accettare ogni cosa che viene perché ciò che accetti è ciò che continua e questo vale soprattutto per le offerte che, ne sarai persuasa, sarebbe stato meglio rifiutare;
– Ricorda che nonostante ciò che dicono i politici, da Berlusconi a Brunetta a Fornero, la parola NO è una tua grande amica: fidati di lei, impara a chiamarla ogni santissima volta che non sai che fare.
2. GLI ALTRI SONO UN OPTIONAL: TI FARANNO PIÙ FORTE E SICURA, MA PUOI ANDARE ANCHE SENZA DI LORO.
Ecco, questo è un punto importante. Dovresti tenere in considerazione l’idea che il confine tra te e le persone non sia un fatto brutto o sconveniente. Anche se da sola non ti senti mai davvero te stessa come ti succedeva una volta quando bastava avere un foglio e una penna o solo un libro; anche se il bisogno di essere accettata dagli altri certe volte è più forte di quello di accettarti da sola con tutte le paure e i difetti che hai; anche se vuoi feste e riunioni e incontri e chiacchiere interessantissime con tutta questa gente nuova, tieni in considerazione l’idea che porre in equilibrio le relazioni che hai e il tuo cuore sia la cosa più difficile e saggia assieme che potrai mai fare. Parlo di amici, di parenti e genitori ma anche di datori di lavoro: non coltivare mai, con questi ultimi, la pianta dell’amicizia. Mai. La useranno contro di te. A fine mese o quando chiederai il rispetto dei tuoi diritti come quello di un contratto, di uno stipendio o anche solo di un luogo di lavoro sereno in cui essere davvero produttiva, aver mantenuto delle barriere ti sarà utile almeno quanto ti fu utile che l’asse della porta a vetri andata in frantumi reggesse. Sugli amici, sugli amori, sulla famiglia, invece, posso dirti solo una cosa, che in fondo sai già: ama. Più che puoi, meglio che puoi, con tutte le forze che hai, con la voglia, la gioia, il desiderio, le arrabbiature del caso. Vivi tutto, che tu non debba mai sentirti colpita da quella domanda di D di Repubblica (il numero 738, per la precisione) che chiedeva:
“Vorreste voltarvi indietro, molto indietro, e urlare alla ragazza che eravate: amalo, maledetta idiota?”.
Sii l’idiota che ama e non preoccuparti: è sempre meglio che essere l’idiota che ha rimpianti. Sii l’idiota che ama e metti al primo posto – va bene, non al primo, ma almeno al secondo o al terzo – anche te stessa. Impara a volere bene anche a lei, a questa tizia squattrinata che gira con i frisé e le unghie mangiate a pelle, che crede a scienze cieche e senza fondamento come la passione per ciò che fa, che è convinta che le buone intenzioni stiano nelle parole come nelle azioni. Ha bisogno di te anche lei, soprattutto lei.
3. PREPARARTI A PERDERE MA NON FARE DELLA SOFFERENZA UN CULTO.
Ti conosco, Raffaella Rosaria Ferré ventiseienne: prenderai le occasioni fornite da altri come tue decisioni. Sei bella anche per questo, al punto che mi viene voglia di abbracciarti, mo’ pe’ tanno, come si dice al paese: ora per allora. Hai pochissime certezze, eppure ti sembra meglio che averne molte, così c’è ancora spazio. Aspetti la vita come si aspetta di leggere i giornali una domenica mattina, con il sole fuori e il caffè caldo: vediamo che è successo, vediamo che succede. Tieni in conto le brutte notizie come quelle buone, tieni in conto la loro evoluzione, ma soprattutto la forma delle stesse: non accontentarti di un verbo sbagliato, di una consecutio non esatta. Non avere fretta e, al contempo, smetti di aspettare: sappi che domani i giornali usciranno di nuovo e che solo per ciò che merita davvero ci sarà quello che chiamano “pezzo di ritorno“. A scriverlo non devi essere sempre tu. Vedrai andare via cose e persone e altre cose e persone arrivare, rocambolescamente e con fare picaresco quasi fossimo in Don Chisciotte e tu, di volta in volta, Alonso Quijano, Sancho Panza e Dulcinea del Toboso. Cambierai lavori uno dietro l’altro come cioccolatini e li amerai tutti, ogni volta come se fosse quello giusto: l’ultimo. Ogni volta come se in una cassetta beta con su registrata la pubblicità da mandare in onda, in un foglio di giornale ancora caldo di stampa, alle 5 e mezza del mattino, in uno scanner A3, in un programma per le Sql e in un convegno sul Terzo Settore, ritrovassi te stessa e un segreto che ti riguarda, importantissimo. Sarà bellissimo. Cerca, però, di fare come fanno i tifosi veri della tua squadra del cuore: ogni tanto canta a te stessa il loro coro da stadio:
Solo la maglia! Conta solo la maglia!
Soffrirai di meno quando qualcuno andrà via per un’offerta migliore o quando dovrai andare tu. Non posso mentirti: ti ritroverai un mercoledì mattina, tra sette anni, con pochissimi spiccioli e molti scampoli di volontà e ti chiederai dove sono finite le guanciotte paffutelle che adesso sono tutto zigomo; ti chiederai perché e a cosa, a chi ti sei lasciata andare, quale lavoro t’abbia mangiato la voglia di credere e quale libro dato la speranza ancora e ancora. Ti domanderai degli amici, quelli che allora c’erano e non ci sono più, quelli che ci sono ancora, quelli che non c’erano allora, non ci sono oggi e che nei momenti bui ti sembra non ci siano mai stati. Sarà allora che capirai che la cosa più importante che tu abbia mai imparato non era sui libri dell’Università: perdere persone e cose importanti e “non fare della sofferenza un culto”, come scriveva Erica Jong. E al di là di tutto questo, oltre tutto questo, i libri, i giornali, le persone, i lavori, le case che hai abitato e i letti su cui hai dormito stanca dopo una notte di parole, saprai che il tempo è sempre a tuo favore e che da te stessa il giorno della laurea non sarai mai troppo lontana. Per tornare indietro un secondo, guardarti, spostarti il ricciolo che cade sempre davanti allo stesso occhio e dirti:
«Certo che ne hai fatte di cazzate tu, eh? Brava! Vogliamo parlare di quella volta che sei finita dentro, anzi, contro una porta a vetri? E questi frisé, ecco: non è che ti sei laureata con una tesi sugli anni Ottanta solo per avere una scusa buona per farti la capa come Barbie Benetton, vero?»